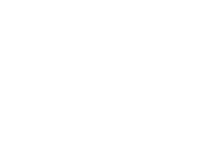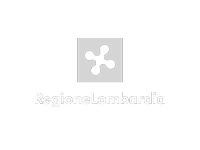Heritage al femminile: Workout magazine incontra Costanza Musso, AD del Gruppo Grendi 1828
In principio erano i caravana. No, non è refuso anche se il termine è una palese corruzione della parola «carovana», a sua volta derivante dal persiano kārwān, a riprova di quello stretto legame linguistico che univa tutti gli ambiti marinari mediterranei con contaminazioni che passavano di nave in nave, da banchina a banchina e che avevano dato vita a una vera e propria lingua franca, il sabir, che era un po’ come l’International English di oggi che fa arricciare il naso ai veri inglesi. Composto da italiano (soprattutto veneto e ligure) e spagnolo, con l’aggiunta di parole turche, catalane, greche, occitane, arabe mediate dal siciliano, il sabir risuonava a bordo delle navi, negli angiporti, nei mercati, parlato dai marinai come dai commercianti, dagli schiavi di Malta così come dai pirati.
Perché i caravana si chiamavano così? Perché anche loro, proprio come i carovanieri dei racconti delle Mille e Una Notte, si spostavano, più precisamente dalle vallate della Bergamasca fino al territorio genovese, anzi fino al porto di Genova in quanto loro, e solo loro, potevano svolgere le operazioni di facchinaggio all’interno della zona della Dogana – e successivamente del Portofranco – dove le merci preziose o quelle soggette a particolari imposte sostavano e potevano essere sballate, magari anche solo per i controlli di rito. La loro presenza è documentata fin dal 1340, data del primo Statuto della Compagnia, che però non menziona condizioni particolari di cittadinanza dei suoi membri. Fu solo a partire da un secolo dopo circa (dal 1487) che venne decretato che chi svolgeva questi lavori dovesse necessariamente provenire da Bergamo o dalla val Brembana con una successiva estensione del privilegio, nel 1576, ai migranti dalla val Brembilla e valle Imagna: «Niuno presumi di venir ammesso nella Caravana, se non sia di Bergamo. Mani grandi et anco gambe forti, per niuna ragione sentir la fatica ammesso» recita un antico statuto della Repubblica di Genova. I motivi di questa scelta si perdono nella notte dei tempi e possono solo essere oggetto di congetture. Quella che è probabilmente una leggenda narra che durante una delle tante pestilenze che periodicamente affliggevano la città, furono soprattutto i lavoratori bergamaschi a prestare assistenza nel raccogliere e seppellire i morti, e per questo motivo furono ricompensati dal Comune con l’esclusiva del facchinaggio, che era un’attività sicura e ben remunerata. Forse più prossima alla verità storica è l’ipotesi che le autorità cittadine avessero deciso di escludere i genovesi da questa funzione perché pensavano che una compagnia «forestiera», proprio in quanto priva di legami con la città, si sarebbe astenuta da intrighi di potere, faide locali e pratiche clientelari.
I caravana erano davvero un mondo a parte: lo si diventava per nascita – addirittura il posto nella Compagnia si poteva tramandare di padre in figlio – tant’è che si vociferava di ragazze genovesi di poverissima origine che andavano nella Bergamasca per farsi ingravidare e poter assicurare a se stesse e al figlio una vita migliore oppure di donne originarie delle valli che una volta incinte vi tornavano per partorire e avere così un’inappellabile «certificazione» DOC per il neonato. E in effetti la Compagnia non lasciava indietro nessuno: i soci venivano aiutati in caso di malattie e infortuni, assistiti in vecchiaia e alla morte – i funerali erano solenni – vedove e orfani venivano tutelati. Dal canto loro i caravana erano tenuti a un comportamento integerrimo: vietati il turpiloquio e la bestemmia, il gioco delle carte era permesso solo alla domenica e quello dei dadi a Pasqua e a Natale, per non parlare di risse e furti che valevano durissime punizioni e talvolta l’espulsione. La loro religiosità era notoria: avevano una cappella intitolata alla Santa Croce nella Chiesa di Santa Maria del Carmine e si obbligavano a partecipare alla Messa almeno in alcune festività comandate. E pazienza se talvolta la devozione si mischiava a necessità pratiche: tanto per fare un esempio, accendevano sempre un lume davanti all’immagine della Madonna in piazza Banchi «tanto per l’amore divino, quanto per la salvaguardia de li banchi contro li ladri», precauzione quanto mai opportuna visto che all’epoca non vi era traccia di illuminazione pubblica e non era certo che la Vergine sarebbe intervenuta contro i malviventi.
Potrei andare avanti a lungo a raccontare di questa confraternita e delle tante vicende della storia di Genova e del nostro Paese che l’hanno vista protagonista fino al suo scioglimento ufficiale a metà dell’Ottocento, ma mi fermo qui. La ragione di questa lunga digressione è che caravana e camalli (questi ultimi sono i facchini generici – denominati da un’altra bella parola di origine turca: hamal – che dei primi presero praticamente il posto e che sono organizzati dal 1946 sotto la CULMV, la Compagnia Unica fra i Lavoratori delle Merci Varie) hanno giocato un ruolo cruciale anche nella storia della famiglia di cui Costanza Musso, AD del Gruppo Grendi, è sesta generazione. E per raccontarlo bisogna partire dall’inizio, scavallando all’indietro di un paio di secoli e portandoci nella Genova borghese ottocentesca, il cui benessere economico ruotava attorno a quel grande formicaio brulicante di uomini e attività che era il porto.
All’epoca i Musso e i Grendi erano spedizionieri. Da quanto con precisione non lo sappiamo, ma esiste una polizza, datata 30 ottobre 1828 e firmata con eleganti svolazzi da un Grendi, Giuseppe di Gaetano, che viene considerata l’atto di nascita dell’azienda. In essa si dichiara che il capitano Giò Batta Borzone di Lavagna prende in carico da Francesco Sommariva due casse di cappelli di feltro, per un valore di 680 lire nuove piemontesi. L’accordo prevede che la merce sarà venduta «a piacimento» del comandante che pagherà Sommariva al ritorno. Garanti e testimoni sono appunto Giuseppe Grendi e tal Giuseppe Benvenuto (di quest’ultimo non abbiamo notizie tranne che il cognome era nel Gotha cittadino di quel tempo). Giuseppe è invece fratello di Marco Antonio Grendi, il fondatore dell’azienda, che da Portofino – dove era nato nel 1807 – si era trasferito a Genova iniziando un’attività appunto di spedizioniere. E i Musso? Di loro riusciamo a risalire a un Giò Batta, nato a Genova nel 1797 e di cui si sa che intorno agli anni Venti dell’Ottocento è anche lui spedizioniere (non deve sorprendere: il lavoro non doveva mancare nel grande ecosistema commerciale del porto).
A quanto pare le due famiglie si conoscono – anche qui nulla di strano, la dimensione della città lo consentiva agevolmente –, ma, di più, vivono nella stessa via e a un certo punto si apparentano per via matrimoniale: Luigi Musso (il figlio più piccolo di Giò Batta) sposa Angela Grendi, figlia invece di Marco Antonio. Sarà l’inizio di un sodalizio solidissimo, affari e famiglia, che alla fine porterà a una sola realtà imprenditoriale, la Grendi. Andiamo però con ordine: Luigi era stato designato a portare avanti l’attività paterna, Angela invece era una donna, destinata – come di consuetudine – alla casa e ai figli, e quindi il cosiddetto scagnu, cioè l’azienda, era passato nelle mani del fratello minore Gaetano. Costui, a sua volta, aveva avuto solo figlie femmine, per di più morte in tenera età, e quindi gli era parso naturale chiamare a un certo punto al suo fianco il nipote Marco Antonio Musso, il figlio più piccolo di Angela Grendi e Luigi Musso. Sarà lui a ereditare, scomparso Gaetano, la Grendi & Figlio nel 1899: ha 37 anni, per l’epoca già un uomo maturo, si è sposato da poco e ancora non sa che la sua azienda e la sua famiglia, dopo aver varcato il nuovo secolo, conosceranno la sciagura della Prima guerra mondiale.
I figli di Marco Antonio Musso saranno tre, il primogenito è Ugo che del nuovo secolo è appunto figlio recentissimo (31 marzo 1900 la sua data di nascita): ci fissa, con lo sguardo fiero e un po’ beffardo che hanno gli adolescenti quando si sentono adulti, da una foto in cui è in divisa. Sì, perché appena diciassettenne, sfidando i dinieghi e le angosce famigliari, si è arruolato volontario, sedotto dalle esaltate parole di Gabriele d’Annunzio che da Quarto d’Altino, due anni prima, aveva arringato i giovani, quelli «affamati di gloria, perché saranno saziati» a gettarsi nella mischia interventista. In quel momento Ugo è troppo giovane per poter andare al fronte, attenderà scalpitando di aver raggiunto l’età minima per entrare nell’esercito e poi parte come Granatiere di Sardegna: è il 5 aprile 1917.
Quanto gli dura l’infatuazione per la guerra, «sola igiene del mondo» come aveva scritto Marinetti qualche anno prima? A giudicare da un diario dove Ugo butta giù i suoi pensieri, a volte poche parole smozzicate, poco tempo, qualche mese. A luglio è sul Carso dove capisce la distanza incommensurabile tra chi predicava appunto l’interventismo e chi invece si trova a fronteggiare contemporaneamente un nemico meglio equipaggiato e la rabbia dei soldati, esausti nelle trincee, esasperati per essere inutile carne da cannone. Si guadagnerà la medaglia d’argento al Valor Militare nell’Undicesima Battaglia dell’Isonzo al prezzo di una gamba menomata, di un anno di prigionia e di fame feroce in un campo di concentramento austriaco e di una disillusione esistenziale che lo rende più vecchio dei suoi diciannove anni effettivi: «I miei sogni svaniti e le mie speranze deluse sono i soli avanzi di questi due anni di vita e me li trascino dietro sorretti a stento dalle mie gambe mal ridotte». Ma almeno è vivo, gli altri oltre tremila giovani genovesi che hanno partecipato alla Grande Guerra non hanno avuto pari fortuna.
In azienda ci entrerà solo una decina di anni dopo, nel 1929, insieme al fratello Sergio: quel lungo intervallo di tempo forse gli è servito per ricostruirsi interiormente, aderisce per un brevissimo periodo ai Fasci di combattimento per staccarsene rapidamente quando capisce che i loro ideali non sono i suoi, va spesso in montagna, si dedica alla musica con più che discreti risultati, ma poi arriva la chiamata del padre che vuole i figli come soci nella Marco Antonio Grendi & Figlio. Ugo non recalcitra di fronte alle responsabilità, può darsi che l’azienda di famiglia non fosse proprio in cima ai suoi pensieri ma sente di non poter opporre un rifiuto: accetta la svolta nella sua vita e diventa imprenditore, accantonando tutto il resto (la montagna però no). Alla morte, nel 1940, di Marco Antonio sarà lui il capo dell’azienda visto che il fratello Sergio ha altri progetti imprenditoriali e gli lascerà di buon grado la sua quota.
Nel giugno di quell’anno l’Italia entra nuovamente in guerra: appena quattro giorni la roboante dichiarazione di Mussolini dal balcone di Palazzo Venezia, Genova viene bombardata dagli aerei alleati. È solo un assaggio di quello che avverrà negli anni a venire e Ugo ne è consapevole. Adesso ha una moglie e tre figli piccoli: è tempo di sfollare, la città non è più sicura. La scelta cade su un paesino del Tortonese che Ugo pensa non verrà sfiorato dai combattimenti. Si sbaglia: proprio in quella zona, dopo l’8 settembre, passerà di tutto: bande partigiane (che Ugo aiuta), milizie repubblichine, reparti della Wehrmacht. Sono anni in cui si viene fucilati per inezie, pericolosi e disagevoli, nei quali si vive in assenza di ogni sorta di comodità, ma nella memoria dei tre figli Musso – Anna, Giorgio e Bruno – resteranno come un periodo di meravigliosa libertà: nessuna regola di sapore cittadino, un’istruzione scolastica poco più che sommaria, giochi sfrenati nei campi insieme ai bambini locali. A guerra finita, il ritorno alla vita consueta non è indolore e forse è per questo che Ugo iscriverà i figli agli scout nel tentativo di far continuare, almeno negli scampoli della quotidianità, quell’avventura continua che aveva contraddistinto la loro infanzia.
Ma…e l’azienda? Finora abbiamo raccontato di vicende famigliari, alcune più intime, altre intrecciate alla grande Storia, ma nulla della Grendi. In realtà questa aveva continuato nel solco aperto da Marco Antonio un secolo prima, con alti e bassi, ma senza mai mutare il proprio DNA: i Grendi erano nati spedizionieri e tali erano sostanzialmente restati. Sarà Bruno Musso (entrato in azienda nel 1961), affiancato dal fratello, a compiere un salto quantico che li porterà a diventare armatori e a rivoluzionare il mondo dei trasporti via mare con quel prezzo sociale che è connesso inevitabilmente a ogni cambiamento tecnologico. Nel 1966 viene varata la Vento di Levante, la prima nave portacontainer operante nel Mediterraneo: nel libro da lui scritto, Il cuore in porto, Bruno racconta che l’inizio di questa nuova fase era stata innescata dalla necessità di abbattere i tempi di carico. L’idea: perché non imbarcare direttamente i rimorchi terrestri? E nel mentre dei progetti di costruzione di una nave traghetto adatta a questo scopo, dagli Stati Uniti era arrivata la notizia della diffusione di una nuova attrezzatura dagli orizzonti commerciali molto promettenti: il container. L’inizio di una nuova era nei trasporti e nell’attività della Grendi che l’aveva subito «sposato».
A quel punto si era però profilato un altro problema: come portare a bordo i container che non avevano ruote? Ci sarebbe voluta una gru in banchina con caratteristiche particolari e quelle non esistevano. È Giorgio ad avere l’illuminazione: costruire una nave che abbia un carroponte a bordo e che sia provvista di un portellone poppiero (è quella sorta di ponte levatoio che ci è famigliare perché presente in tutti i traghetti) e la coperta carrabile. Era il 1969 e di lì a breve il varo della Vento di Tramontana avrebbe dato il via a un lungo e battagliero braccio di ferro tra i Musso e la CULMV, la compagnia dei portuali. Inevitabile: l’avvento dei container chiudeva l’epoca del monopolio dei camalli sulle attività del porto di Genova perché le navi diventavano autonome nelle operazioni di carico e scarico e ancora una volta, come in altri momenti della Storia a partire dall’introduzione del telaio meccanico nell’Ottocento, si fronteggiavano le istanze progressiste della rivoluzione tecnologica e quelle sociali legate alla perdita di posti di lavoro.
Uno scontro duro e combattuto senza esclusioni di colpi, fino alla decisione dei Musso, nel 1972, di lasciare Genova e portarsi a La Spezia concentrando la propria attività soprattutto sui trasporti verso e dalla Sardegna, che da decenni era meta privilegiata della Grendi. Troppo complicato restare nella città natìa, l’insostenibilità della situazione aveva avuto pesanti ripercussioni sul buon andamento del lavoro, i clienti si diradavano e i bilanci facevano presagire il peggio, addirittura il fallimento. Si rivelerà una scelta saggia: nel giro di un decennio l’azienda si riprende, vengono aperte nuove linee e costruite altre navi, il fatturato si rialza prepotentemente. Ci sarebbe di che essere soddisfatti, ma c’è, appunto, un «ma», che porta il nome di Genova. La città persa, le radici dissotterrate: Bruno ne soffre, ci vuole tornare, forse anche contro quello che gli detterebbe il buon senso. E ci riuscirà: negli anni Novanta, dopo una lunghissima vertenza con la CULMV, al termine della quale alla Grendi verrà riconosciuto il diritto di sbarcare presso un proprio terminal e di operare utilizzando il proprio personale. Prima però ci sarà stata un’aspra contrapposizione anche fisica, quella che Il Secolo XIX chiamerà «Sfida all’OK Corral»: i portuali per due volte impediscono alla Vento di Levante di abbassare i portelloni e scaricare e solo al terzo tentativo, il 14 luglio 1992, cederanno di fronte al rischio di uno scontro sanguinoso con le forze dell’ordine. La Grendi ha vinto e diventa il primo terminalista privato del porto di Genova. In questo «finale di partita» veramente beckettiano resta solo lo spazio per tante riflessioni, molto attuali a dire la verità, sulle transizioni tecnologiche e il loro impatto, a 360 gradi, sulla società.
Da allora sono passati più di trent’anni e il Gruppo Grendi continua a crescere: quattro terminal (Marina di Carrara, Olbia, Cagliari RORO – cioè destinato a navi che scaricano e caricano merci su ruote tramite rampe – e Cagliari LOLO – per le navi che invece sollevano i container con gru), quattro navi, tratte internazionali verso il Nord Africa in aggiunta a quelle nazionali, magazzini negli interporti di Milano Opera, Bologna e Genova Bolzaneto, tre centri logistici in Sardegna, un nuovo spazio direzionale in progetto a Marina di Carrara. Cresce anche il fatturato, portandosi nel 2024 a 117, 6 milioni di euro con un + 20% rispetto all’anno precedente. Chi ha avuto la pazienza di arrivare fino a qui nella lettura noterà che non si parla più di un terminal a Genova: in effetti dal 2011 non c’è più, per mancato rinnovo della concessione portuale. La ragione? Viene indetta una gara per l’assegnazione dell’area Multipurpose del porto, la cordata di cui Grendi fa parte la perde perché la cordata concorrente ha previsto investimenti maggiori. Che però, va detto, non verranno mai realizzati, ma intanto Genova è stata lasciata. Inizialmente le attività si spostano a Vado Ligure per poi approdare (è il caso di dirlo) a Marina di Carrara quattro anni dopo.
Alla testa del Gruppo due figli di Bruno, Costanza e Antonio. Una vera rivoluzione familiare: per la prima volta dopo quasi 200 anni una donna «comanda» in azienda. Lei dice sempre ridendo che è stata cooptata perché in quel periodo (era il 1996) la situazione in azienda era così critica che non faceva più differenza se al timone ci fosse una donna o un uomo. Esagera volutamente, è vero però che in quel momento di crisi, aggravato da un infarto di Bruno, il figlio minore Eugenio, già in azienda da un anno aveva chiamato i fratelli a raccolta: «Ci ha detto: “Ragazzi, se volete entrare in azienda dovete farlo finché c’è, perché qui le cose non vanno bene e non è che resistiamo tanto”. Io a quel tempo lavoravo a Milano in una società di indagini di mercato, un’attività che tra l’altro mi piaceva molto, mio fratello Antonio invece viveva in Germania. Entrambi però ci siamo decisi a fare questo passo».
L’ha spinta lo «spirito di servizio», lo stesso a cui aveva obbedito il nonno Ugo quando aveva scelto di appendere l’amato violino al chiodo per occuparsi dell’azienda. I primi anni durissimi: «Innanzitutto dal punto di vista economico perché il risultato ha ricominciato a essere positivo nel 2004, dopo ben sette anni. In aggiunta a questo avevamo problemi a Genova e a Cagliari non ci davano i permessi per costruire il nuovo magazzino. Vivevo con un carico di ansia pesantissimo, che alle volte si traduceva in un malessere fisico che non riuscivo nemmeno bene a interpretare». Oggi Eugenio ha scelto un’altra strada, pur rimanendo socio, e Costanza divide la leadership con Antonio, una situazione che non le pesa minimamente, anzi: «Potrei dire che è il nostro punto di forza. Perché la diversità di genere in un’azienda funziona molto bene e a maggior ragione se c’è un rapporto di fratellanza. Perché ci si conosce alla perfezione e se hai un vissuto positivo reciproco– e noi l’abbiamo – sai riconoscere quando aiutare l’altro, puoi a tua volta farti assistere in caso di necessità in totale fiducia, senza doverti guardare le spalle. Poi certo, noi due abbiamo caratteri molto diversi e più di una volta ci sono stati momenti in cui non eravamo d’accordo. Però ha sempre prevalso l’idea che l’azienda venisse prima di tutto e sulla base delle sue necessità o l’uno o l’altro faceva un passo indietro. E se abbiamo fatto degli errori, l’altro non glieli ha mai rinfacciati. Insomma prevale e deve prevalere sempre lo spirito di coesione, il desiderio di condivisione e la capacità di collaborare».
Mi chiedo e chiedo a Costanza Musso se suo padre, oggi Presidente del Gruppo, aveva mai pensato a lei calata nel ruolo che oggi occupa. La risposta è sincera (e affettuosa nei confronti del genitore): «Lui, come tutti quelli della sua generazione, è maschilista, nel senso che pensa ci siano cose da uomini e cose da donne. Però in un certo senso mi ha sempre spinto a non aderire agli stereotipi, a non temere di andare anche controcorrente. Mi diceva: “Sei brava, sembri quasi un vero ometto” e così facendo mi ha tirato fuori il senso della sfida, la voglia di mettermi in gioco. Quindi gliene sono grata».
Certo che il rapporto di Bruno Musso con i figli è stato veramente peculiare: fin dalla primissima infanzia li ha portati in viaggi sfidanti – in canoa da Spalato a Dubrovnik, trekking in Lapponia, il giro dell’Olanda in bicicletta, i Pirenei a piedi – per abituarli alla resilienza e a introiettare il principio che «c’è sempre una via di uscita in tutte le criticità», un addestramento che sarebbe stato loro utile anche nella vita lavorativa; per un certo periodo ha fatto vivere la famiglia in una sorta di comune agricola a Sarzana, lontano dalle sirene del consumismo; pare calasse Costanza bambina dalla tromba delle scale appesa a una fune per insegnarle a non temere il vuoto. Un po’ di quello spirito è sopravvissuto nelle lunghe estati passate alle Eolie quando ormai i tre fratelli erano diventati a loro volta genitori: «Vacanze spartane, zero lussi, sempre in spiaggia, che hanno creato tra i nostri figli un forte spirito di cuginanza. Anche così li prepariamo a diventare la nuova generazione in Grendi. E alcuni di loro in effetti hanno già cominciato a fare esperienze in azienda» dice Costanza.
Nel novembre di quest’anno Grendi è diventata B Corp, prima realtà del trasporto marittimo e della logistica integrata a raggiungere questo status nel mondo: «Fin da quando abbiamo deciso di seguire il percorso delle Società Benefit nel 2021, la volontà che ci ha guidato è stata quella di avere una visione chiara di come secondo noi si dovesse condurre un’azienda. Siamo partiti da tre nostri capisaldi: ambiente, territorio e persone. Ambiente perché il nostro business è impattante e dobbiamo perciò mitigarne gli effetti; territorio perché abbiamo costruito un legame biunivoco con esso, il territorio ci dà tanto e noi dobbiamo restituire; persone perché rappresentano un valore imprescindibile – lo si è ben capito nel post Covid – e oggi trovare talenti e saperli trattenere è una delle sfide più importanti per un’azienda. Se individuare questi punti è stato relativamente facile perché erano già “nostri”, successivamente, con la volontà di diventare B Corp, abbiamo dovuto misurare e rendicontare tantissimi parametri, dal consumo dell’acqua allo smart working alla governance, in un processo molto lungo e rigoroso, che ha coinvolto un team di nostri manager e di cui eravamo informati passo a passo ma nel quale non abbiamo voluto intervenire, io per prima ho fatto un passo indietro anche se normalmente sovraintendo a questi progetti. Così facendo, tutta una serie di azioni sono adesso diventate parte integrante del bagaglio culturale della nostra azienda».
Il rapporto con il territorio ha nella scuola uno degli interlocutori privilegiati. Costanza Musso è molto soddisfatta delle iniziative messe in campo, a partire da Portolab, un progetto in collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, che ha portato 400 alunni della scuola primaria di Massa Carrara nel porto: «Tutti i lunedì avevamo in visita qualche classe, davamo ai bimbi un sacchetto con caschetto, giubbottino catarifrangente e un po’ di gadget, li facevamo salire a bordo e gli aprivamo un container per mostrare cosa c’era all’interno. Un modo per avvicinare loro e le loro famiglie al mondo marittimo visto che Massa Carrara è una realtà anche portuale». E poi il rapporto con gli Istituti Nautici: a docenti e allievi è stato offerto di trascorrere un weekend su una delle navi, facendo vita di bordo e nel contempo assistere ad alcune specifiche lezioni. «Aderiamo all’alternanza scuola-lavoro con un numero di ore importante, il che ci permette tra l’altro di individuare ragazzi a cui possiamo poi offrire opportunità di lavoro. E cerchiamo di svolgere un ruolo di mentor nei confronti di queste scuole, aiutandole a far capire ai ragazzi che il mondo marittimo è molto interessante e ricco di sfaccettature».
Costanza, come tutte le donne che hanno infranto il famoso «soffitto di cristallo», è molto sensibile anche al tema dell’empowerment femminile: «In Grendi le donne rappresentano il 14% delle nostre persone ma il 42% delle posizioni apicali, ed è proprio questo il punto. Non è una questione di quante donne ci sono in un’azienda, ma di quante di loro hanno accesso a ruoli di responsabilità. Capita che imprenditori uomini mi sottolineino che il 50% dei loro collaboratori sono donne e poi quando chiedo quante di loro si trovano posizioni di vertice scopro che sono, se va bene, il 10%. È il contrario quello che fa la differenza, quello è il vero empowerment femminile». E le donne, secondo lei, hanno la capacità straordinaria, affinata nei millenni, di non «strappare» mai le situazioni, di riuscire a tenere tutto insieme, eventualmente anche di ricucire laddove invece gli uomini, per raggiungere un obiettivo, non si pongono il problema di travolgere tutto quello che si para loro davanti: « Sono due atteggiamenti che in una realtà imprenditoriale vanno visti come complementari, non come stili in contrapposizione, l’obiettivo è ricomporli in una visione unitaria che dà ottimi risultati». Opinioni dettate dall’esperienza di co-leadership con il fratello? Forse, ma non lo chiedo. Poi Costanza aggiunge: «Mi piace però sottolineare che, quando nel 2019, c’è stata la possibilità di una candidatura a Cavaliere del Lavoro mio fratello mi ha detto “Provaci, sei una donna, magari hai più chance” e così è stato. Sono rarissimi i casi di famiglie con più fratelli imprenditori in cui la scelta ricade sulla sorella». Una coppia, quindi, veramente di acciaio.
Da venticinque anni Grendi fa parte di AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari) di cui Costanza Musso è Chief Ambassador: «A suo tempo ho deciso di entrarci perché avevo bisogno di capire meglio cosa volesse dire avere un’azienda di famiglia, quali avrebbero potuto essere problematiche e opportunità e come gestire al meglio le une e le altre. E nell’Associazione ho imparato praticamente tutto quello che oggi so. È stata un’ottima palestra perché lì hai l’esempio di imprese più grandi della tua, puoi vedere cosa fanno, partecipare a incontri con professori universitari su temi specifici. E io, che sono una sorta di spugna che assorbe tutto per poi rielaborare, grazie a questi momenti ho capito tante cose, giusto per fare un paio di esempi, l’importanza di avere una governance strutturata e degli indipendenti nel CDA. Sempre lì ho visto le prime aziende Benefit e B Corp che mi hanno poi ispirato. AIDAF diventa così una sorta di «scuola d’impresa» che è fondamentale perché puoi fare tutti i master del mondo, ma poi sei solo su tante scelte e avere la possibilità di confrontarti con chi magari ha già percorso quei passi diventa prezioso». AIDAF insegna anche a coinvolgere le generazioni successive fin da quando sono giovani, cosa che ai fratelli Musso non è accaduto: «Nel 1991 mio padre e suo fratello hanno diviso l’azienda dicendosi che lo facevano perché poi noi non litigassimo. Ma in AIDAF impari che puoi anche essere in 120 in famiglia e non litigare perché ci sono regole e procedure, perché ciascuno viene coinvolto sulla base delle sue possibilità, delle sue necessità e dei suoi desideri».
L’approccio di Costanza a questo ruolo istituzionale è passionale ed entusiastico, le piace andare nei territori non solo per cercare nuovi soci ma anche per mettere in campo iniziative che siano di formazione piuttosto che di networking oppure di comunicazione e promozione. È la stessa passione con cui mi parla di WISTA, Women International Shipping and Trade Association, di cui è Presidente per L’Italia: «L’Associazione nasce a Londra nel 1974 ed è arrivata in Italia vent’anni dopo. Riunisce professioniste ai più alti livelli dei settori marittimo, commerciale e logistico quindi broker, armatrici, agenti marittimi, spedizioniere, ma anche avvocate, commercialiste, con l’obiettivo di colmare il gender gap nel nostro mondo, fare rete, scambiarsi best practice, incrementare e favorire la nostra formazione professionale, ma soprattutto farci riconoscere portatrici di professionalità e competenze». WISTA oggi riunisce seimila socie di sessanta Paesi diversi che una volta all’anno si incontrano per discutere di temi anche molto pratici. E dulcis in fundo, Costanza è anche Vicepresidente dell’UICI, che raggruppa le imprese italiane che hanno almeno un secolo di vita e che, con la loro storia e le loro attività, costituiscono un patrimonio culturale, oltre che economico, di grandissimo valore. La loro mission? Promuovere l’importanza dell’heritage nel mondo imprenditoriale, sottolineando quanto sia un punto di forza anche dal punto di vista del legame con il territorio.
Tutto questo senza perdere quel filo di autoironia e di sense of humour che si intrecciano nei suoi racconti, come quando, alla domanda su cosa pensa abbia apportato lei ad AIDAF in questi tanti anni, risponde ridendo: «Innanzitutto del colore! Prendo sempre in giro le mie amiche dell’Associazione dicendo “Ragazze, guardate che anche se evitate di mettervi tutte in tailleur scuro e camicia bianca vi prendono sul serio lo stesso!». O come quando racconta dell’orto impiantato sul terrazzo di casa che per quindici anni è stata la sua «via di fuga» nei momenti di maggior tensione: «Negli anni in cui a Genova diventavo matta per trovare una concessione, l’unica cosa che mi rilassava veramente, una volta tornata a casa, era strappare le erbacce dai vasi».